| Home | Archivio | Artisti | Mostre | Gallerie | Calendario | Ocra | Hozro | Avanguardie | Links | |||||||||||||||||||||
 | ||||||||||
|
| ||||||||||
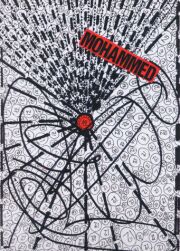 |
LA MONTAGNA E LA
RETE: MOHAMMED di Sandro
Ricaldone Ancora non
distanziato nel tempo quanto basti per consentire un accostamento sul piano
storico, Mohammed si reinventa in un presente ove lo scenario della
comunicazione, se non dell’arte, si presenta radicalmente mutato rispetto alla
situazione in atto poco più di una ventina d’anni or sono. Allora, con
l’eccezione del mezzo televisivo (rimasto sostanzialmente inaccessibile agli
artisti) l’articolazione delle reti comunicative poteva dirsi sostanzialmente
omologa a quella esistente all’inizio del ventesimo secolo, imperniata su
stampa, posta, manifesto, telefono e radio. Nell’ambito di questo sistema,
schemi di diffusione tendenzialmente universali e monodirezionali (stampa,
pubblicità, televisione) si alternavano a scambi che oggi si direbbero peer
to peer, basati essenzialmente sul telefono e sul tramite postale, con
qualche apertura sul versante radiofonico, grazie alle trasmissioni aperte
all’intervento in diretta del pubblico, divenute popolari negli anni ’70. Nonostante gli
esperimenti dei Futuristi (sulla posta e la radio) e le intuizioni degli
Spazialisti (a proposito della televisione) o - sul versante telefonico - di un
autore beat come John Giorno, promotore dell’operazione “Dial-a-Poem”, è stato
solo con Ray Johnson e la Mail Art che si è concretizzato, a partire dagli anni
’60, un duraturo intreccio fra attività artistica e circuito comunicativo. Un simile
riconoscimento va però temperato da una constatazione di segno diverso. In
effetti la Mail Art, al di là di taluni aspetti mimetici (uso di timbri e di
francobolli, questi ultimi, sovente, d’invenzione) utilizza la rete postale per
ciò che è, come veicolo di trasmissione di messaggi verbovisivi, realizzati su
supporti cartacei (o equivalenti). Non vi si dà una messa in questione dello
strumento comunicativo o della comunicazione in sé stessa. Si mette in scena,
piuttosto, un debordare dell’arte dai suoi ambiti tradizionali. Ed anche la
comunità planetaria che grado a grado si è venuta realizzando fra i mailartisti,
pur prefigurando in qualche modo analoghe aggregazioni formatesi in seguito sul
world wide web, non sembra il frutto di un progetto coscientemente
perseguito ma di un processo in larga misura imprevedibile. Assai diverso è il
punto di partenza di Mohammed, ciclo intrapreso da Plinio Mesciulam nel
maggio 1976, che sin dall’inizio si pone invece - volutamente - come
laboratorio di comunicazione. Nella prima fase,
limitata a dodici destinatari (più che interlocutori veri e propri), muovendo
da una scelta che oggi verrebbe bollata come spamming per i risvolti
d’intrusione nella privacy che implicava (“voi non mi cercate, ma io vi ho
cercato”), l’autore ha tradotto in una realtà debitamente fittizia un circuito
articolato su molteplici livelli, in cui – volta a volta – venivano esplicitati
o “criptizzati” mittente, ricettore e messaggio. L’analisi, condotta non di
rado sul filo del paradosso logico, si concentra sui tratti di verità e di
finzione dello scambio epistolare, sugli snodi fra informazione e disinformazione,
accostando temi divenuti d’attualità negli anni ’90 con le rielaborazioni
neoiste di spunti dada e situazionisti: l’idea dell’autore anonimo-collettivo e
il continente del plagio, lambito nella copia
“scritta con mano tremante” dell’Infinito leopardiano e la
teorizzazione dell’artista come vampiro ma già puntualmente messo a fuoco nello
scambio con Armando Battelli di una pagina lukàcsiana firmata (anche) da
quest’ultimo e intitolata Intervento critico non anonimo. Nel secondo
momento l’attenzione si sposta sulla rete, con La possibilità, per il
destinatario, a diffondere il messaggio, moltiplicandolo esponenzialmente
(secondo uno schema analogo a quello delle “catene”) ed a retroagire sul
mittente. Con ciò Mohammed-Mesciulam proclama la sua profezia, anch’essa - va
precisato - non definita negli sviluppi ma certamente calcolata: quella di una
diffusione planetaria del messaggio, tramitata da soggetto a soggetto, in grado
di attivare una trama di rimandi potenzialmente illimitata. Oggi Mohammed Due,
attivato solo da qualche giorno, sembra reclamare, à rebours, benché sul
punto di espandere la propria ramificazione in Internet, la dimensione
individuale (ancor più ristretta di quanto non dicesse in origine la
sottointestazione del Centro) della comunicazione. Ma deve ormai fare i conti
con i replicanti spersonalizzati delle chat. | |||||||||
| Lettera sulle arti a Genova - a cura di Sandro Ricaldone | Home Top Contact |